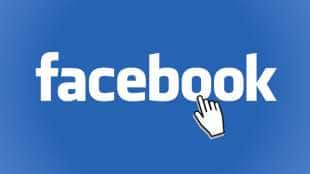La parola del giorno è
[con-ci-tà-to]
SIGN Agitato, che manifesta emozione; vivace, incalzante
da [concitare], uguale in latino da cui è
recuperato come voce dotta, intensivo di [concire] o [conciere]
'eccitare, incitare', derivato di [ciere] 'muovere, agitare, chiamare'.
Per quanto sia comunemente noto e usato, questo è un aggettivo sottile e incisivo, e ha una grazia profonda che merita ragione.
Se dicessimo che è
sinonimo
di 'agitato' non saremmo fuori strada, anzi; ma nel concitato troviamo
un movimento più complesso. Dico un movimento perché anche se l'agitato,
l'eccitato, l'incitato, il concitato non evocano gesti precisi, sono
qualità di inquietudine vibrante, mossa, che si
declina in maniere diverse.
Se l'agitato, dentro, fuori, frigge palpita e si rivolge, il concitato colloca questa inquietudine
emozionata
in una situazione. Quel 'con-', al solito, è tutto: evoca insieme,
relazione, e fa del concitato una manifestazione di sentimento
echeggiante - ne trema l'aria. Insomma, posso essere agitato o eccitato
nel pozzo astratto della mia mente, ma il concitato chiede circostanze,
se non
addirittura condivisione. Inoltre non si presenta in maniera direzionata: l'eccitato esonda da dentro a
fuori, l'incitato a capofitto si
volge in un verso - il concitato no. Il concitato, nel manifestare l'emozione agitata, echeggia, si riprende, interferisce,
comunica. Tanto da diventare anche il vivace, l'incalzante, mai in un tratto singolo astratto, sempre in una dinamica viva concreta.
Ci ricordiamo il momento concitato
dell'esposizione dei quadri coi voti dopo l'esame di maturità;
sentendoci la pressione addosso diamo una risposta concitata prendendoci
meno tempo di quanto sarebbe stato saggio fare; la ricerca concitata
della chiave nella sabbia si
conclude con un sospiro di sollievo; il ritmo concitato della canzone si scioglie in un ritornello ampio.
È curioso come una parola così difficile sia usata con tanta
disinvoltura.
* * *
[tàn-fo]
SIGN Odore pesante e sgradevole
dal longobardo [thampf] 'vapore'.
Nella
galassia di parole esatte che la nostra lingua ci apparecchia per gli odori sgradevoli, il tanfo è uno degli astri più luminosi.
'Tanfo' è una delle parole portate
all'italiano dai Longobardi, nella lingua dei quali il suo omologo aveva
il signficato di 'vapore' (peraltro dalla stessa radice trae origine il
tedesco moderno
Dampf, con questo stesso significato). Ora, usare il significato di vapore per
intendere il puzzo è
piuttosto
intelligente e molto calzante:
comunica
in modo incisivo la natura di effluvio del puzzo, di esalazione, un
passaggio di sostanze nell'aria che promanano da una fonte malsana. Ma
resta da capire quale
peculiare tipo di puzzo sia il tanfo (purtroppo non sarà una passeggiata fra i glicini).
Il tanfo è pesante, stagnante. Non è
un odore sottile e tagliente, ma grosso, grasso, che occupa e ammorba
l'aria; non è mobile e volatile, ma fermo, quasi solido - hai voglia ad
aprire le finestre. Accettando e seguendo la
suggestione
di una vicinanza non etimologica con un'altra parola, il tanfo si
allarga nel suo mezzo come un tonfo, grave, echeggiante, di cui non si
sente la fine. Come il tonfo, il tanfo resta lì.
Si trova scritto nei dizionari che
il tanfo è in specie un malodore di muffa, di umido, di chiuso, ma è
un'osservazione esageratamente pulita: il tanfo sa essere sulfureo,
batterico. La sua non è una sgradevolezza che fa arricciare il naso
sensibile:
è ripugnante, colpisce le viscere - concretamente o figuratamente. Le
cipolle trascurate si vendicano imputridendo con un tanfo cadaverico,
impallidiamo al tanfo che grava durante lo spurgo (anche se il tecnico,
con vena filosofica, ci
conforta dicendoci che è nulla in confronto al tanfo morale che si respira in città), e il tanfo di una
compagnia ci
ricorda in un attimo perché non la frequentiamo.
Grave, intenso, stagnante, permanente:
caratteri d'olfatto che solo una parola potente come questa sa evocare.
* * *
[và-no]
SIGN Vuoto, cavo; incorporeo; privo di sostanza, di contenuto, d'effetto; spazio
dal latino [vanus].
Sì, il vano umido dell'ascensore, i
cinque vani dell'attico di pregio, l'ampio vano portabagagli sono esiti
quotidiani del 'vano' letterario. Ma andiamo con ordine.
Il vanus latino è una parola grande, che nei rapporti con parole affini - come vacare e vastus - ci fa intravedere la radice antica, indoeuropea, del vuoto. In effetti il vanus
latino, come aggettivo, indicava in concreto proprio il vuoto, il cavo,
il privo di contenuto o di sostanza, l'inconsistente. Giusto le prime
qualità che riconosciamo nel nostro vano: se al picchiettare della nocca
il muro suona vano, è meglio non tentare di appenderci la specchiera
pesante, alla fine della vana merenda abbiamo ancora una fame
terrificante, il cane abbaia al vano gonfiarsi delle lenzuola stese
fuori.
Il passo al significato figurato è
tanto breve quanto capitale, e ci rende un vano che è privo di valore,
di fondamento, di corpo ideale, soprattutto di effetti fruttuosi - una
vescica vuota, illusoria, o
frivola. Dissipiamo la vana
paura e facciamo ciò che è giusto, l'argomento vano si infrange sull'affermazione
intelligente,
il discorso vano ci annoia. Di qui anche il sostantivo, da accostare
ciò che è inutile: il vano diluisce una bella storia, confonde una
ricetta. Di qui anche la locuzione avverbiale
in vano, che vale per 'inutilmente' e conosciamo meglio come
invano, unito: ti chiamo invano al telefono, evidentemente lo usi solo per Instagram.
Ma il vuoto è anche spazio; e se
letterariamente il vano può essere uno spazio grande e indefinito
(perfino l'aria stessa), quotidianamente diventa uno spazio
definitissimo, uno spazio di azione, di vita, e lo troviamo in
abitazioni, contenitori, suddivisioni.
Così il vano finisce di presentarsi
come una parola di spessore, di altezza poetica e di funzionalità
ordinaria, che ragiona significati torniti da ogni lato.
______________________________
L. Ariosto, Orlando furioso, canto XXXIV, strofa 75
Le lacrime e i sospiri degli amanti,
l'inutil tempo che si perde a giuoco,
e l'ozio lungo d'uomini ignoranti,
vani disegni che non han mai loco,
i vani desideri sono tanti,
che la più parte ingombran di quel loco:
ciò che in somma qua giù perdesti mai,
là su salendo ritrovar potrai.
Questo celebre canto narra il volo
di Astolfo sulla luna: il luogo dove si radunano tutte le cose perse e
dove lui spera di recuperare il senno di Orlando, impazzito per amore.
E qui il tema
basilare del poema, la vanità dei
desideri
umani, si fa esplicito: la vita è osservata da un punto di vista
straniante (la luna), apparendo in tutta la sua piccolezza e futilità.
Molti autori moderni, come Leopardi o
Pirandello, utilizzano tale straniamento in una chiave tragica,
mostrando una vita priva di senso e costellata di
delusioni.
In Ariosto però il tema ha ancora una sfumatura ludica. La vita, sembra dirci il poeta, va vissuta con
leggerezza:
lasciamoci trasportare dai sogni, ma senza la pretesa che si realizzino
sempre; e ricordiamo che molte cose per cui ci affanniamo non sono poi
così importanti. Tale leggerezza, che tanto piacerà a Calvino, non è una
forma di superficialità, ma un modo per conoscere il mondo senza
farsene impietrire.
L’Ariosto ci mostra così che la vita
umana è piena di cose vane, che passano senza dare risultati concreti:
l’amore infelice, il tempo del gioco e dell’
ozio,
i progetti sognati, e soprattutto i desideri. E così facendo ci invita
alla moderazione e al buon uso del tempo, in modo da cogliere le
occasioni prima che scompaiano.
Forse, però, il vano non è del tutto
privo di valore. In fondo Astolfo scopre che le cose perse non sono mai
veramente perdute. Non solo: proprio le cose piccole, vane e sciocche
fanno vivere la narrazione. Senza i pazzi desideri dei personaggi il
poema non sarebbe tanto affascinante; anzi, non sarebbe neppure
cominciato. E lo stesso si può dire, del resto, per la vita stessa.
Perciò nell’ironia di Ariosto c’è
anche una certa tenerezza verso quei piccoli esseri umani che, malgrado
tutto, sperano sempre, tentano tutte le strade per essere felici. Il
che, in fondo, è una forma di grandezza.
* * *
[de-i-scèn-za]
SIGN In botanica, proprietà di certi apparati vegetali di aprirsi spontaneamente; in medicina, riapertura di una ferita suturata
da [deiscente], voce dotta recuperata dal latino [dehiscens], participio presente di [dehischere] 'spaccarsi, aprirsi'.
Ancora una volta siamo davanti a una parola poco nota che significa qualcosa di ben noto, quotidiano, e tanto
suggestivo. (Scoprire questo genere di parole dà un gran letizia.)
Pensiamo al fico maturo, che
sensualmente si fessura e ci invita a coglierlo prima che vi entrino le
vespe; pensiamo al baccello che si
squarcia appena,
lasciando intravedere le fave al suo interno. Questa è la deiscenza. La
proprietà che hanno certi apparati vegetali chiusi di aprirsi
spontaneamente: se il verbo 'deiscere' ci suona
desueto,
ce la possiamo far suonare come un'ipotetica 'aprenza'. Peraltro non è
una parola che vive propriamente solo in botanica, ma anche in
medicina,
dove meno simpaticamente diventa la riapertura della ferita che era
stata suturata: la deiscenza del taglio ricucito è una complicazione
post-operatoria, l'assoluto riposo scongiura la deiscenza. Ora, come
s'immagina una suggestione del genere invita dei significati figurati:
per esempio il detto verbo 'deiscere', oltre ai singificati di 'aprirsi,
spalancarsi', aveva anche
quelli di 'stupirsi, meravigliarsi' - aperture delle più belle e
profonde. E anche se quel ramo è ormai secco, possiamo trarne
ispirazione.
Possiamo parlare della deiscenza di una
curiosità, naturalmente allargata da un'esperienza eccitante; della deiscenza di un'idea matura che si
spalanca a spargere semi; della deiscenza della persone
timida che finisce per aprire la sua intimità; di come il lavoro
paziente, senza fretta, attende sicuro la deiscenza di una
realizzazione.
Questo è il potere della deiscenza: significare un'apertura spontanea, volentieri
fertile. Non è di certo la parola che usiamo più spesso, ma significa un
fenomeno, una proprietà che è ben presente nella nostra osservazione del mondo - ed è bello avere una parola così esatta.
* * *
[ac-quie-scèn-te]
SIGN Remissivo, accondiscendente
dal latino [acquiescens], participio presente di [acquièscere] 'acconsentire', composto di [ad-] 'a' e [quiescere] 'riposare'.
Questa parola
formidabile comunica un concetto con una sfumatura di un'esattezza
prodigiosa. Quando si dice che la nostra è una lingua raffinata parliamo anche di casi come questo.
Per
apprezzare questa raffinatezza va notato che l'acquiescente (è difficile anche scriverlo) ha una
galassia di sinonimi:
remissivo,
accondiscendente, arrendevole, conciliante, accomodante,
docile, sottomesso, e via e via. Ma il
remissivo
si rimette al volere altrui, l'accondiscendente vi aderisce,
l'arrendevole alza le mani e cede, il conciliante e l'accomodante ne
convengono, il docile e il sottomesso vi ubbidiscono. L'acquiescente ci
parla invece di quiete.
Ce ne parla in una maniera precisa: il verbo latino quiescere
è un incoativo, cioè descrive l'iniziare di un'azione - in questo caso
l'acquietarsi, il calmarsi. Così l'acquiescente ci si presenta come la
qualità di chi si sta volgendo alla quiete, e in particolare di chi,
entrato in contatto con una volontà esterna, ne è tranquillamente
persuaso, serenamente convinto, senza l'increspatura di un'obiezione,
senza un pensiero ruvido o dissonante.
Un
factotum
acquiescente ai capricci dell'artista serve a costruire il personaggio;
ci mostriamo cortesemente acquiescenti a una decisione, intendendo
scambiare il nostro favore presente per un altro
futuro; l'erede si dichiara acquiescente a volontà testamentarie
bizzarre;
per la piacevolezza della
compagnia siamo così poco interessati al menu che ogni vivanda proposta ci trova acquiescenti; e dopo tanto
crucciato pensare optiamo acquiescenti per l'
articolo che ci ha consigliato il commesso
suadente.
Nel bene o nel male, l'acquiescente è
uno specchio d'acqua che si calma come se un immissario ne smorzasse
l'agitazione. Non è certo un'immagine grossolana. E si vede in maniera
lampante quale sia la differenza con ogni altro suo sinonimo.
* * *